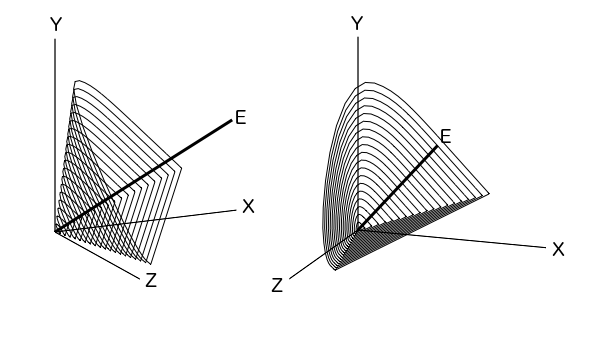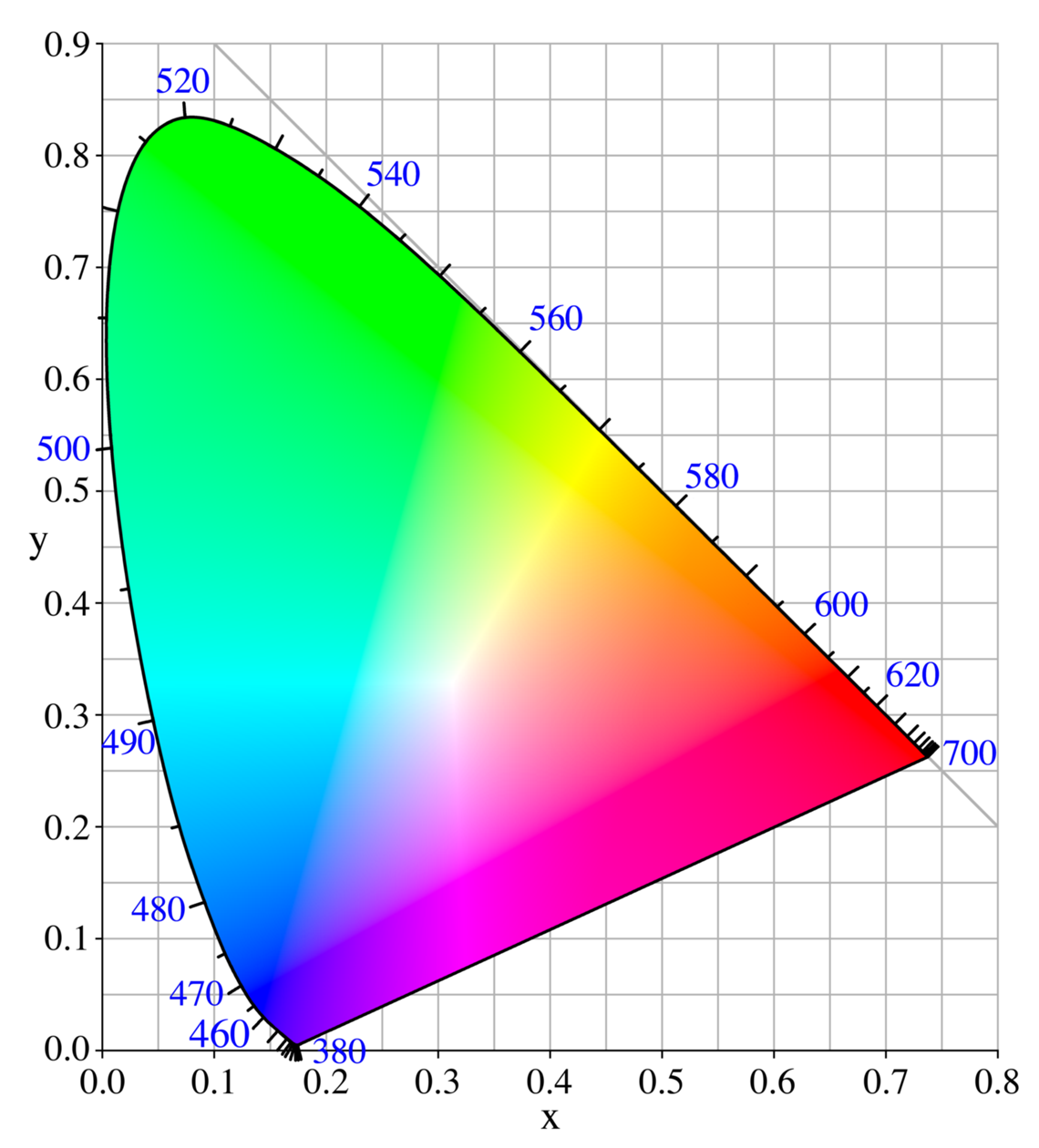<< Paragrafo precedente << >>Paragrafo
successivo >>
Lo spazio colorimetrico CIE 1931
Le coordinate colorimetriche X, Y, Z
Come si è detto la definizione dello spazio colorimetrico CIE 1931 per
la rappresentazione dei colori trae origini dalla definizione delle “curve
di imitazione del colore” che, pur non rappresentando la
sensibilità spettrale dei fotorecettori dell’occhio, ne sono in
corrispondenza biunivoca.
Le tre coordinate X, Y, Z rappresentano, lo ripetiamo, la stimolazione di
tre sensori scelti con tre opportune sensibilità spettrali (di forma
corrispondente alle “curve di imitazione del colore”
dette anche "funzioni colorimetriche") , in modo
che, misurando due colori metamerici (ossia che appaiono uguali) si si
otterrà la medesima terna dei valori X, Y, Z.
Chi fosse interessato a conoscere le funzioni
colorimetriche, definite punto per punto, con un
intervallo di 5 nm, esse sono state determinate sperimentalmente e
scaricabili dal sito ufficiale della CIE come foglio di calcolo di Excel.
Sebbene sarebbe possibile anche determinare altre 3 curve di imitazione del
colore, non è vero il contrario: ossia che 3 qualsiasi sensibilità spettrali
permetterebbero di rispettare questa proprietà, che è fondamentale per
potere parlare di spazio colormetrico.
In altre parole nel colorimetro a filtri mostrato nella pagina precedente
non avremmo potuto mettere tre qualsiasi filtri rosso verde e blu. È
necessario mettere tre filtri aventi per spettro delle curve di imitazione
del colore.
La scelta delle curve di imitazione del colore fatta dalla CIE nel 1931 è
stata fatta inoltre affinché le coordinate che si ottengono godano anche
delle seguenti, fondamentali (e comode) proprietà:
- qualsiasi colore fornisce sempre valori della coordinate mai negativi:
X ≥ 0; Y ≥ 0; Z ≥ 0;
- uno stimolo equienergetico (quello fornito da un colore
acromatico, ossia privo di tinta) fornisce tre coordinate uguali tra
loro: colore acromatico ⇔ X=Y=Z;
- la coordinata Y è stata scelta in modo da rappresentare la luminanza
del colore: luminanza = Y.
La luminanza, essendo una grandezza fisica
misurabile, fornisce quindi direttamente la misura dell'attributo
percettivo della brillanza.
Lo spazio colorimetrico CIE 1931, rappresentato nelle coordinate X, Y, Z
può venire rappresentato come nella figura qua sotto:
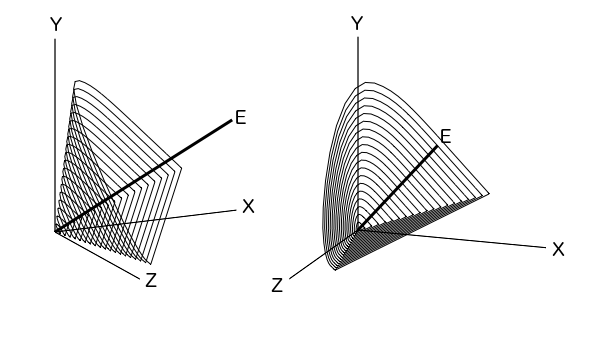
Lo spazio colorimetrico CIE 1931 nelle
coordinate X,Y, Z, visto da due diverse angolazioni.
Si osservi la particolare forma a "cono schiacciato" del gamut,
che si estende all'infinito nel caso dei colori autoluminosi: tutti i colori
reali stanno al suo interno; sulla superficie curva stanno
i colori monocromatici, sulla parte piatta, in
basso, stanno i magenta bicromatici.
La retta uscente dall'origine è il luogo dei colori acromatici, ed è detta retta
acromatica o equienergetica.
Nell'origine è collocato il nero. Allontanandosi dall'origine, spostandosi
lungo la retta equienergetica, poiché aumenta il valore della Y (la
"quota"), che rappresenta la luminanza, si va verso i grigi e i bianchi via
via più luminosi.
I blu occupano la zona più prossima all'asse Z, i verdi la zona più prossima
all'asse Y, i rossi la zona più prossima all'asse X.
Ogni colore è rappresentato da un punto.
Se due colori giacciono su una stessa retta uscente dall'origine, essi
avranno la medesima tinta e la medesima saturazione
(quindi hanno la stessa cromaticità), ma
ovviamente non la stessa luminanza (quello più
esterno sarà più luminoso).
La sintesi addittiva nello spazio XYZ
La sintesi addittiva di due colori viene fatta
semplicemente sommando rispettivamente i valori delle tre coordinate, come
nell'esempio che segue:
- colore A (è un rosso):
- XA = 2,5
- YA = 4,0
- ZA = 3,5
- colore B (è un blu):
- XB = 4,0
- YB = 2,0
- ZB = 4,0
sintesi addittiva:
- colore C = A+B (è un magenta):
- XC = 2,5 + 4,0 = 6,5
- YC = 4,0 + 2,0 = 6,0
- ZC = 3,5 + 4,0 = 7,5
Un semplice visualizzatore di colore
È possibile visualizzare un colore inserendo le coordinate nelle caselle qua
sotto. Avvertenze:
- possono essere inseriti numeri interi o decimali, utilizzando
indifferentemente "." o ",";
- se vengono inserite le coordinate di un colore fuori gamut, ossia non
reale, il visulizzatore ne dà avviso;
- se un colore non è visualizzabile dal monitor, il visualizzatore lo
attenuerà e lo desaturerà automaticamente per visualizzarlo, dandone
avviso;
- inserendo 3 valori uguali verrà visualizzato lo stimolo
equienergetico. Questo appare, in modo più o meno marcato a seconda del
monitor utilizzato, come un bianco piuttosto "caldo": ciò dipende da
diversi fattori:
- dalla calibrazione del monitor;
- dall'angolazione di osservazione: i monitor LCD tendono a cambiare
la colorimetria cambiando l'angolo di osservazione;
- dal fatto che lo stimolo equienergetico è un colore neutro di
riferimento. In realtà, a causa dell'adattamento cromatico, noi
ricoosciamo come neutri colori che sono anche un po' diversi tra loro.
Coprendo le parti bianche del monitor (che sono più "fredde") e
osservandolo al buio si tenderà a perdere la sensazione di "tonalità
calda";
- inserendo invece i valori X: 0,9495, Y: 0,9990, Z: 1,0872 i valori RGB
del monitor corrisponderanno a 255, 255, 255 che è il bianco di
riferimento del monitor;
- inserendo, ad esempio, i valori X: 0,4123152, Y: 0,2126, Z:
0,0193273, che corrispondono esattamente alle coordinate
colorimetriche del rosso 255,0,0 si otterrà tale colore;
Significato generale delle trasformazioni delle coordinate degli spazi
Trasformare uno spazio significa trasformare le sue coordinate mediante
delle regole. Queste regole possono essere delle formule matematiche, ma
anche un algoritmi (ossia un procedimento fatto di una successione di
formule, o altre regole). A volte le trasformazioni sono estremamente
semplici, in altri casi sono tanto complesse da richiedere un gran numero di
calcoli ripetuti, per cui sarà necessario svolgerle mediante un calcolatore.
Se abbiamo a che fare con uno spazio di 3 dimensioni, i cui punti sono
determinati da 3 coordinate (come nel caso di uno spazio colorimetrico), la
trasformazione porterà ad avere almeno altre 3 coordinate nel nuovo spazio.
La trasformazione potrebbe portare anche a un numero maggiore di coordinate,
ma in questo caso quelle eccedenti la terza non saranno indipendenti dalle
altre 3.
Schematicamente, in termini del tutto generali, potremmo rappresentare una
trasformazione che porta da tre coordinate X1, Y1, Z1, ad altre tre X2, Y2.
Z2 in questo modo:
________________
X1
|
| X2
Y1 -->|
trasformazione |--> Y2
Z1 |________________|
Z2
Di una trasformazione può esistere anche la sua inversa, che ci permetterà
di tornare alle coordinate iniziali, in questo caso:
________________
X2 |
trasformazione | X1
Y2 -->|
inversa |-->
Y1
Z2 |________________|
Z1
Le coordinate colorimetriche x, y, Y
La rappresentazione dello spazio colorimetrico CIE 1931 nelle tre coordinate
spaziali X,Y, Z, pur essendo suggestiva, non è tanto pratica in quanto non
può essere rappresentata sul piano, come ad esempio su di un foglio.
Per questo la CIE ha proposto la rappresentazione nelle tre coordinate x, y,
Y alle quali si giunge mediante una semplice trasformazione:
x = X/(X+Y+Z)
y = Y/(X+Y+Z)
Y = Y (ovviamente!)
si può inoltre prendere in considerazione
un'ulteriore nuova coordinata:
z = Z/(X+Y+Z) che però di solito non si utilizza poiché non dà nessuna
informazione aggiuntiva: è infatti dipendente da x e da y. Infatti è
sempre:
x+y+z =1 (per mostrarlo basta mettere tre qualsiasi valori al posto di X,
Y, Z e calcolare x,y, e z), per cui z = 1-x-y. Quindi z viene di
conseguenza una volta note x e y.
Esiste anche la trasformazione inversa, che in
certi casi torna utile:
X = (x/y)*Y
Y = Y (ovviamente!)
Z = [(1-x-y)/y]*Y
Abbiamo così due nuove coordinate x, y che possono essere rappresentate su
un piano, e, insieme, danno informazioni sulla cromaticità (tinta e
saturazione) di un colore.
La coordinata Y, invece continua a rappresentare la luminanza, e non viene
trasformata, quindi non può venire rappresentata su tale piano.
Il piano che risulta è il noto piano di cromaticità x-y, detto anche
scherzosamente, a "ferro da stiro" o a "ferro di cavallo".
::Qui si può scaricare una
pagina A4 stampabile del grafico.
::E qui, per risparmiare carta,
una pagina A4 con 4 grafici.

Un punto sul piano xy rappresenta una cromaticità, o, in altre parole, tutti
i colori che hanno quella cromaticità (ma anche differente luminanza).
La linea a forma di "ferro da stiro" rappresenta le cromaticità dei colori
monocromatici nella parte curva, e dei magenta bicromatici nella parte
inferiore rettilinea.
Sulla parte curva sono indicate le lunghezze d'onda corrispondenti.
Il punto equienergetico
Il punto equienergetico E, rappreentando la cromaticità di un colore che ha
coordinate X = Y = Z ha coordinate:
- xE = 1 / (1+1+1) = 0,333
- yE = 1 / (1+1+1) = 0,333
Al solo scopo di visualizzare dove sono collocate le varie cromaticità
(quindi non si pretenda alcun tipo di fedeltà cromatica), ecco un
diagramma illustrativo colorato:
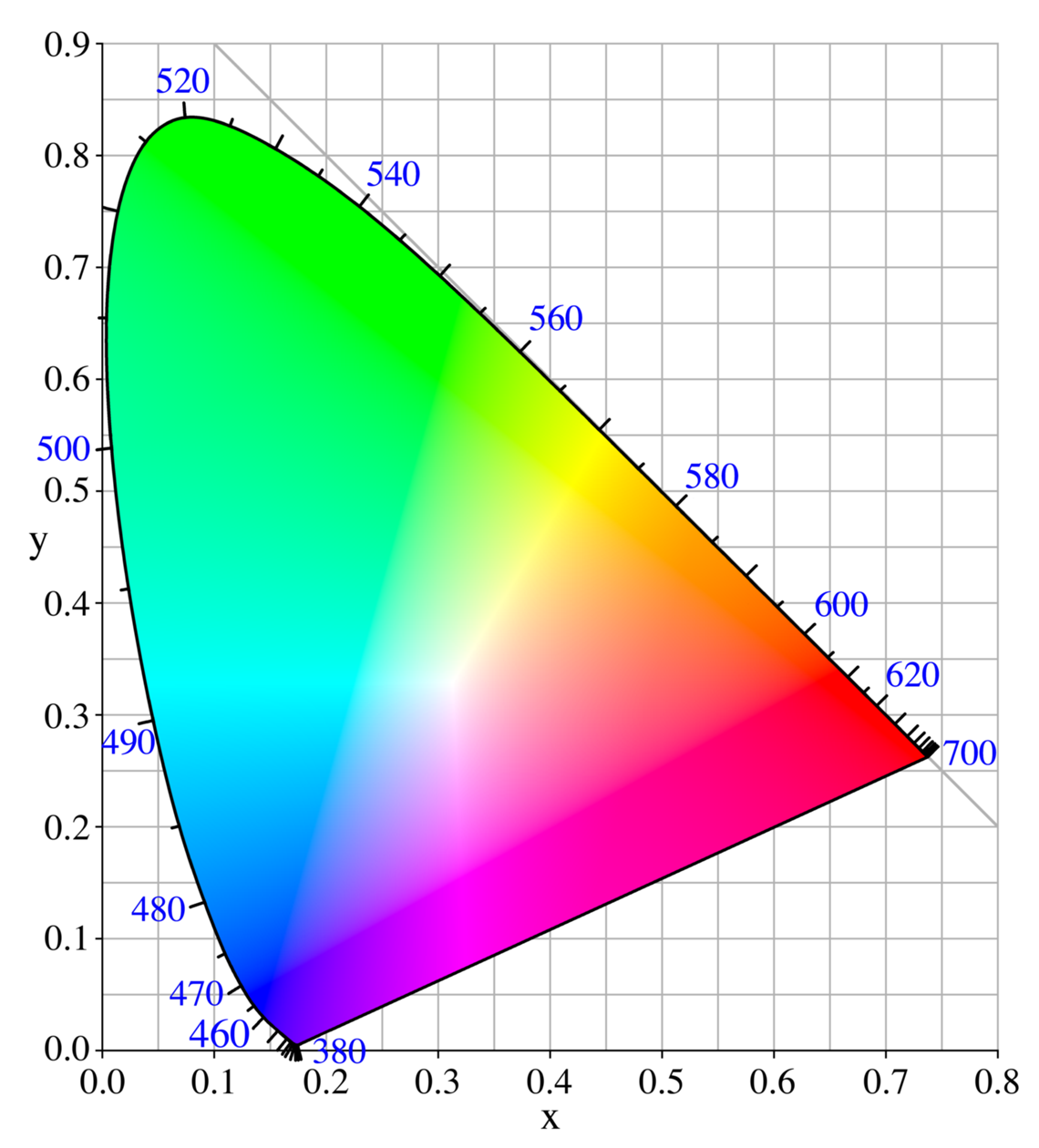
dove si vede dove sono collocati i blu (lunghezze d'onda più piccole), i
cyan, i verdi, i gialli, i rossi e i magenta. Verso il centro i colori
perdono di saturazione fino a diventare acromatici.
La sintesi addittiva nel piano di cromaticità xy
Le cromaticità dei colori dell'esempio precedente saranno rappresentate da
dei punti aventi coordinate:
- colore A
- x = X / (X+Y+Z) = 2,5 / (2,5+4,0+3,5) = 0,25
- y=Y / (X+Y+Z) = 4 / (2,5+4,0+3,5)= 0,40
- Y= 4,0
- colore B
- x = X / (X+Y+Z) = 4,0 / (4,0+2,0+4,0) = 0,40
- y=Y / (X+Y+Z) = 2,0 / (4,0+2,0+4,0) = 0,20
- Y= 2,0
- colore C = A+B
- x = X / (X+Y+Z) = 6,5 / (6,5+6,0+7,5) = 0,325
- y=Y / (X+Y+Z) =6,0 / (6,5+6,0+7,5)= 0,300
- Y= 6,0
Dove si vede, collocando con attenzione i punti sul piano x-y, che
il punto rappresentante la cromaticità del colore C, sintesi addittiva
di A e B, sta sulla congiungente i due punti rappresentanti le
cromaticità di A e di B.

Non si commetta l'errore di sommare direttamente tra loro le coordinate x
e y!
La lunghezza d'onda dominante come misura della tinta nello spazio
CIE 1931
Si noti che se si prende un qualsiasi colore C e lo si miscela in modo
addittivo con il bianco equienergetico (punto E) , per la proprietà appena
vista prima il colore C' che ne risulta sta sulla congiungente il punto C
con il punto E.

Lo stesso ragionamento si può ovviamente fare a partire anche da un
colore monocromatico CM.
Poiché aggiungendo bianco a un certo colore, il colore che ne risulta ha
la stessa tinta, ma minor saturazione, ne consegue che tutti i punti che
giacciono sulla stessa semiretta che esce dal punto E hanno la stessa
tinta, ma saturazione via via crescente da 0 (il punto E, per il quale non
è nemmeno identificabile la tinta) fino a incontrare il limite del gamut,
dove avremo la maggior saturazione possibile (quella del colore
monocromatico CM, o del magenta bicromatico se andiamo a finire
sulla linea dei magenta).
Questo fatto si può utilizzare per dare un valore della misura della
tinta.
Dato un colore C, la misura della sua tinta può essere data dal valore
della lunghezza d'onda del colore monocromatico CM che ha la
medesima tinta del colore C.
Tale lunghezza d'onda è chiamata lunghezza d'onda dominante
del colore C preso in esame, e, nell'esempio sopra vale 500 nm.
Ovviamente, poiché hanno stessa tinta, è anche la lunghezza d'onda
dominante del colore C', così come di tutti quelli che stanno sulla stessa
semiretta rappresentata.
Qualora però il colore C giacesse nella zona triangolare compresa tra il
punto monocromatico di lunghezza d'onda 380nm (che è l'"estremo blu" della
linea dei magenta, di coordinate circa x=0,174 e y= 0,005), il punto
monocromatico di lunghezza d'onda 780nm (che è l'"estremo rosso" della
linea dei magenta, di coordinate circa x=0,737 e y=0,263), e il punto
equienergetico E, avremmo a che fare con un magenta, e quindi non potremmo
determinare la lunghezza d'onda dominante (i magenta sono almeno
bicromatici), e quindi la misura della sua tinta verrà data mediante la
lunghezza d'onda dominante complementare, ossia la
lunghezza d'onda del colore monocromatico che sta dalla parte opposta
rispetto al punto E.

Nell'esempio qua sopra il colore C è un magenta, e pertanto la sua lunghezza
d'onda dominante non potrà essere espressa. Si dovrà esprimere pertanto la
lunghezza d'onda dominante complementare, che in questo caso vale 550 nm.
Pertanto, ad esempio, se sappiamo che un colore ha lunghezza
d'onda dominante pari a 525 nm, capiamo che si tratta di
un verde.
Se invece sappiamo che un colore ha lunghezza d'onda dominante
complementare pari a 525 nm, capiamo
che si tratta di un magenta.
La lunghezza d'onda dominante, e la lunghezza
d'onda dominante complementare
per i magenta, rappresentano pertanto la misura
della tinta nel piano di cromaticità xy dello spazio CIE
1931.
La purezza di eccitazione come misura della saturazione nello spazio CIE
1931
Abbiamo detto che partendo dal punto equienergetico E, e muovendosi su
una semiretta verso il limite del gamut, la tinta non cambia mentre cambia
la saturazione. La posizione su tale semiretta può essere pertanto
utilizzata come misura della saturazione.
Se un colore coincide col punto E, ha saturazione minima, pari a zero, e
la sua tinta non sarà identificabile.
Se un colore giace sul limite del gamut, sarà un colore monocromatico, o
un magenta bicromatico, e la sua saturazione sarà massima.
Se un colore giace a metà strada tra il punto E e il punto del colore
monocromatico (o magenta bicromatico) avente la stessa tinta, avrà
saturazione intermedia
Pertanto la misura della saturazione di un
colore C, sul piano di cromaticità xy dello spazio CIE 1931, sarà data
dalla purezza purezza d'eccitazione, che vale i
rapporti tra le distanze indicate di seguito:
purezza d'eccitazione del colore C = CE
/ CME

e per i magenta:
purezza d'eccitazione del colore C = CE
/ CBE

Graficamente sarà necessario eseguire col righello le misure di CE,
CME
e CBE ed
eseguire i rapporti.
La purezza di eccitazione si può esprimere anche come valore percentuale,
semplicemente moltiplicando x 100.
A questo link un comodo
visualizzatore interattivo del piano di cromaticità con calcolatore di
lunghezza d'onda dominante e purezza di eccitazione.
Gli spazi cromatici RGB
La proprietà vista prima, per cui un colore che è sintesi (o miscela)
adittiva di due colori A e B è rappresentato nel piano di cromaticità xy
da un punto C che è situato sul segmento della retta congiungente i punti
che rappresentano i colori A e B, si traduce nel fatto che avendo a
disposizione tre colori primari:
tutti i possibili colori ottenibili dalla miscela di questi tre colori
saranno per forza interni al triangolo i cui vertici rappresentano i tre
colori primari stessi.
Lo spazio cromatico sRGB è uno spazio "standard"
utilizzato per rappresentare i colori riproducibili da un monitor "medio",
ossia non professionale, utilizzato come standard del web, allo scopo di
far sì che un determinato colore sia rappresentabile all'incirca allo
stesso modo su qualsiasi monitor.

Tale spazio ha un gamut che nel piano di cromaticità xy è appunto un
triangolo non particolarmente esteso.
Altri spazi RGB standard, rivolti a usi più professionali, come lo spazio
Adobe®RGB hanno un gamut un poco più esteso.
Il bianco che si ottiene miscelando in egual misura i suoi tre primari
non coincide con il colore E equienergetico, ma con un bianco che ha
coordinate leggermente diverse, uguali a quelle di un illuminante "D65"
(il cui significato sarà chiarito più avanti, al paragrafo "Illuminanti
standard"):
Le coordinate xyY dei primari utilizzati sono rappresentate nella tabella
che segue:
|
R rosso
|
G primario verde
|
B primario blu
|
W bianco (D65)
|
x
|
0,6400
|
0,3000
|
0,1500
|
0,3127
|
y
|
0,3300
|
0,6000
|
0,0600
|
0,3290
|
Y
|
0,2126
|
0,7152
|
0,0722
|
1,0000
|
Un colore definito nelle tre coordinate xyY (o XYZ, visto che è sempre
possibile passare da un sistema di coordinate all'altro con le
trasfornazioni viste nel paragrafo "Le
coordinate colorimetriche x, y, Y") può essere trasformato nelle
coordinate sR, sG, sB (il prefisso "s" è utilizzata per indicare che
stiamo utilizzando lo spazio sRGB) mediante una trasformazione (piuttosto
complessa, come calcolo, volendola fare manualmente)
________________
x
|
| sR
y -->|
trasformazione |--> sG
Y |________________|
sB
le 3 nuove coordinate sR, sG, sB hanno valori compresi tra i noti limiti
0 e 255 (per essere codificabili con 8 bit)
Se nella trasformazione si ottiene anche uno solo dei 3 valori sR, sG, sB
minore di 0 o maggiore di 255, significa che il colore è al di fuori del
gamut triangolare dello spazio sRGB, e non potrà essere rappresentato da
un monitor che funziona secondo lo standard sRGB. Dovrà allora essere
fatta una "correzione" del colore (correzione che prende il nome di
"intento di rendering") per poterlo rappresentare, ma il colore che verrà
rappresentato sarà giocoforza un'approssimazione.
È quello che viene fatto nel visualizzatore
di colore visto prima, quando appaiono gli avvisi:
- il colore mostrato è attenuato
- il colore mostrato è desatrato
che indicano le correzioni per potere visualizzare il colore (quando
invece appare l'avviso "fuori dal gamut" si intende che sono state
inserite delle coordinate che non corrispondono a un colore reale, ma
fuori dal gamut assoluto).
<< Paragrafo precedente << >>Paragrafo
successivo
Livio Colombo
Alcuni diritti riservati:

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative
Commons Attribuzione
- Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.